|
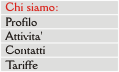

|
Calabria:
uno sviluppo impossibile
Francesco
Longo
Da
sempre i teorici dello sviluppo
economico, economisti e sociologi, hanno dato non poca importanza al ruolo
dei fattori culturali nei processi di sviluppo e di crescita.
Diversi
studiosi come Rostow o Lewis, ma non solo, si sono sforzati a spiegare lo
sviluppo economico secondo i criteri dell’unicità del processo e dei
mutui benefici. Ne è emerso che, nonostante i pareri contrastanti
sugli effetti dello sviluppo economico e sulle tipologie che lo stesso
processo può innescare nella società, la formazione della popolazione è uno
degli elementi essenziali. La teoria della dipendenza, secondo la quale “si
intende una situazione in cui l’economia di alcuni paesi è condizionata
dallo sviluppo e dall’espansione di un’altra economia, alla quale la prima
è sottomessa” , è un esempio del fatto che realtà maggiormente pronte ad
affrontare i diversi mercati si allontanano da altre realtà completamente
impreparate, mentre l’espansione e lo sviluppo di queste ultime è
strettamente riflesso e condizionato dalla crescita dei paesi cosiddetti
dominanti.
Da
diversi anni, quindi, in particolare con l’elaborazione da parte di
Inglehart di una banca dati sui valori mondiali (World Values Survey),
costituita presso l’Università del Michigan, si è data minore importanza a
quella visione unidirezionale che considerava i processi socioeconomici
legati unicamente a fattori strutturali. Un esempio eclatante è dato dalle
varie politiche per il Mezzogiorno, che hanno privilegiato gli investimenti
in risorse materiali, trascurando la formazione, dando i risultati già commentati.
Sicuramente la cultura e la formazione di una popolazione sono rilevanti,
ma non per questo bisogna abbandonare
le riforme strutturali, che da sole, ribadiamo, non bastano.
Diversi
studi negli anni precedenti hanno confermato casi di insuccesso di politiche
di sviluppo orientate unicamente ad uno sviluppo prettamente strutturale;
in realtà non esiste un vincente tra idealisti e materialisti, la soluzione
è quella di saper integrare bene le due teorie, considerando la cultura
come fattore sempre presente, intendendolo quindi secondo l’accezione data
da Triandis nel 1996: “c’è ampio accordo sul fatto che la cultura consista
di elementi comuni che forniscono istruzioni standard per percepire,
ipotizzare, valutare, comunicare e agire, in una popolazione che condivide
la stessa lingua, la stessa epoca storica e la stessa localizzazione
geografica. Tali elementi comuni vengono tramandati attraverso le
generazioni con qualche modifica. Essi sono costituiti da assiomi non
verificati e da procedure operative standard che riflettono ciò che ha
funzionato nel passato, in un certo punto della storia di quel gruppo
culturale”.
La
tesi elaborata dal professore Marini concretizza e mostra il ruolo dei
fattori culturali nei processi decisionali intendendoli come un filtro che
condiziona l’attore economico.
Una
volta accertato che queste risorse immateriali sono essenziali, bisogna adesso capire quali sono questi
fattori che caratterizzano i diversi atteggiamenti e che portano differenti
realtà economiche e sociali.
Il
modello di Inglehart modificato dal professor Marini evidenzia che i valori
favorevoli alla crescita economica sono il senso di responsabilità e la
voglia di indipendenza, mentre l’ostacolo dominante allo sviluppo è l’obbedienza, poiché la ricerca del potere e
l’autoritarismo impediscono ai mercati di avviarsi e di funzionare con
efficienza.
La
voglia di indipendenza si rivela la motivazione prevalente che spinge
l’individuo ad avviare attività imprenditoriali misurandosi apertamente con
i mercati e quindi con i concorrenti esterni.
Il tema, affrontato da Schumpeter, è ripreso anche da alcuni studi di
Trigilia che vedremo in seguito.
Anche
il senso di responsabilità, connesso alla voglia di indipendenza, è un
elemento portante da non sottovalutare nell’intenzione di avviare il
modello precedentemente descritto.
Nel
Mezzogiorno, ed in Calabria in particolare, questi valori non mancano. Il paradosso
quindi vede la Calabria come una regione tra le più dinamiche nel
Mezzogiorno secondo questi indicatori. Allora perché risulta ancora il
fanalino di coda per quanto riguarda gli aspetti puramente economici? La
soluzione è da trovare nel terzo valore che caratterizza la Calabria e
convive in conflitto con gli altri due: l’obbedienza.
La lunga introduzione a questo lavoro,
che delinea la situazione economica e sociale della regione e della
provincia, presenta una terra che è stata sempre dominata, che ha quindi
avuto sempre un governatore a cui rendere conto. Mostra inoltre una
Calabria che si è sempre, in parte volutamente, sottomessa a comandanti esterni, e che non ha tentato, se non in
sporadici casi particolari, di ribellarsi. Questa è un’altra differenza con
diverse regioni del nord, che hanno sempre cercato di sconfiggere gli
occupatori facendo prevalere l’identità locale, mentre al contrario la
Calabria mostrava segni di asservimento e quindi di tacita e consapevole
sottomissione.
Prevale
quindi in questa ed in altre regioni del Mezzogiorno quel senso di obbedienza già accennato.
La
popolazione reggina, e non solo, ha
sempre visto e vede tutt’ora lo Stato come un ente esterno
alla società locale, obbligato a
dare, assistere e mantenere il benessere, e che invece “ruba” le risorse.
Da qui la costruzione del processo che considera lo Stato come un
soggetto da raggirare e imbrogliare
per riavere ciò che detrae.
Nonostante
infatti non manchino in diverse realtà interne alla regione il senso di responsabilità
e di indipendenza, questa concezione dello Stato rimane, accompagnata dalla
propensione all’obbedienza.
Nonostante
i dati siano riferiti al 1996, analizzandoli attentamente notiamo che non
fanno altro che riproporre la
Tre Italie delineate da Bagnasco già nel 1977. L’autore
infatti analizza i dati puramente economici nazionali e divide l’Italia in
tre aree: l’Italia nord-occidentale, caratterizzata dalla grande impresa
che ha trainato e imposto il modello di sviluppo nazionale; l’Italia del Centro
Nord-Est, costituita dallo sviluppo creato in forme particolari dalla
piccola impresa; “il Meridione, infine, è l’area del sottosviluppo
relativo, dove l’economia si è disgregata e riorganizzata in dipendenza da
esigenze esterne”.
L’analisi
di Bagnasco è orientata a dimostrare, e ci riesce, che in realtà le tre
conformazioni economiche sono caratterizzate da tre diverse formazioni
sociali, che hanno influito non poco nei processi di sviluppo.
La
struttura di classe, il sistema politico e i dati culturali hanno
contribuito a delineare le tre situazioni apparentemente diverse in tema di
mercato del lavoro,
decentramento produttivo e piccola impresa.
È
essenziale quindi comprendere la storia sociale e i rapporti in particolare
nelle campagne, per giustificare le posizioni attuali. L’analisi storica
per Bagnasco è comunque complementare, egli infatti privilegia infatti le nuove
diversità, cioè i rapporti più recenti che hanno aumentato questi
distacchi tipici di un ormai retorico contrasto Nord/Sud.
L’emergere
di una borghesia industriale moderna, e quindi del proletariato
industriale, hanno caratterizzato il processo industriale del Nord. Al Sud,
invece, la dominanza di una borghesia agraria parassitaria sulla
disgregazione contadina, ha costituito la stagnazione del mondo agricolo.
I
processi reali del capitalismo nelle sue varie fasi sono caratterizzati dal
blocco storico “che controlla la formazione e asseconda i modi
dell’accumulazione industriale, coinvolgendo lo Stato nella gestione…”.
Bagnasco
si sforza quindi di spiegare perché una borghesia più tradizionale e
agricola ha bloccato lo sviluppo del meridione, e come invece una borghesia
più orientata alla trasformazione e al cambiamento (e sicuramente più
dinamica nei rapporti centro-periferia) ha innescato processi di sviluppo
con successo. Quello che manca nell’analisi, e sicuramente non è compito di
questa tesi dimostrare, visto che lo studio necessita di analisi più
approfondite e per le quali diversi sociologi ed economisti si stanno
impegnando, è la ricerca delle cause reali di queste differenze. Non viene
cioè spiegato come due, o meglio tre formazioni originariamente uguali si
trovino a subire un continuo distacco. Sicuramente non sono da trascurare la Rivoluzione Industriale
e la vicinanza geografica delle due aree del Nord agli affari centrali
dello sviluppo, ma non solo. La storia della Calabria, unica per eventi e
naturalmente imparagonabile ad altre realtà, è caratterizzata da strutture di classe
totalmente differenti da quelle delle regioni del nord-ovest e del
nord-est, che spiegano i vari clientelismi e legami a rapporti sterili di
cui questa regione è purtroppo ancora protagonista.
La
consapevolezza e l’assenso sociale hanno permesso di instaurare
da parte dello Stato una modernizzazione forzata, imposta dall’alto, che ha
comportato forti discrepanze tra Stato e mercato. Sappiamo infatti che,
dove la forza sociale si è proposta come alternativa complementare, stato e
mercato sono cresciuti di pari passo, costruendo strutture economico –
sociali quasi complete. La mancanza di una forza attiva in questa
provincia, dovuta, come già detto, alla formazione culturale esistente, ha
impedito l’emersione di una società che riuscisse a “gestire” l’intervento
pubblico e aiutare le
istituzioni alla crescita. La modernizzazione, quindi, intesa come il
continuo ampliamento della sfera d’influenza delle due entità (stato e
mercato, appunto), si può dire che in Calabria non è avvenuta, o meglio che
presenta timidi casi sporadici di emersione, ma senza ottenere benefici
tangibili. Esempi eclatanti sono l’operato della Cassa per il Mezzogiorno e
tutte le altre politiche di sviluppo per il Sud, che non potranno mai avere
successo se sono viste solo come un obbligo
di distribuire ricchezza, e se non si entra in un’ottica imprenditoriale
produttiva. Da pochi anni a questa parte, come già analizzato nel primo
capitolo, sono nati in Calabria, in particolare nel cosentino e nel
crotonese, alcuni distretti industriali che fanno ancora fatica a crescere.
L’isolamento della Calabria è dovuto quindi soprattutto ai diversi eventi politici e alle
sbagliate formazioni sociali, che hanno creato una regione debole nel
confronto con competitors nazionali
ed esteri. Ne è un esempio la
recente entrata nel mercato di paesi come la Spagna o la Grecia, che hanno
decimato le esportazioni di prodotti agroalimentari calabresi.
Il
problema da risolvere è allora quello di cercare di modernizzare stato e
mercato grazie ad una partecipazione attiva e complementare delle due
istituzioni. Per questo è necessario introdurre nella società regionale una
cultura economica rivolta
all’investimento e all’innovazione permanente. Questo perché allo stato attuale,
qualunque sia l’intervento tecnocratico (o dall’alto), sarà sempre
sfruttato per creare una rendita a breve e non per generare risorse a
medio–lungo termine, visto il solito concetto di Stato assistenzialista.
I
processi di modernizzazione attuati finora, hanno comportato casi di
successo e casi di fallimento. Lo scopo è quello di analizzarne le
differenze per capire quali sono gli elementi concreti che possano favorire
il successo delle politiche pubbliche
e private orientate allo sviluppo, in particolare per fare in modo che
questi sistemi turistici non si rivelino dei fallimenti perché
costituiscono forse l’ultima carta da giocare per tentare il decollo.
Agricoltura e turismo sono stati in
diversi punti della regione fattori di sviluppo economico. Anche lo storico
Manlio Rossi Doria affermava che il passaggio da un’agricoltura estensiva
ad una intensiva è stato l’unico vero elemento di modernizzazione presente
in Calabria, ed ha creato veri e propri imprenditori che hanno fatto della
terra la principale fonte di ricchezza, se di ricchezza si può parlare.
Negli anni Settanta e Ottanta, infatti, sono nate alcune cooperative a
gestione familiare che hanno intuito il business del settore orientandosi
all’esportazione dei prodotti agricoli anche all’estero,
ciò è stato possibile grazie all’acquisizione delle competenze tecniche
capaci di competere, all’individuazione dei potenziali e reali mercati di
destinazione, e la persistenza e la
pazienza di aspettare il reddito consapevoli che può generarsi grazie ad
economie di scala. Altri casi di successo possono essere individuati nel
turismo, settore molto più recente di quello agricolo, dovuto al rientro
delle risorse umane, quindi degli emigranti che in periodi di forte crisi
avevano abbandonato la Calabria,
che hanno acquisito e intuito i possibili fattori di sviluppo, e hanno con
incredibile coraggio scommesso in attività redditizie sfruttando le risorse
naturali della regione. Tra i casi di insuccesso troviamo invece le
politiche pubbliche, come le
spese in agricoltura e gli incentivi ai giovani imprenditori. Questo
smentisce il fatto che le regioni con problemi di sviluppo sono
caratterizzati da una bassa spesa pubblica.
Il problema, infatti, è il metodo di utilizzazione di questa spesa. È
necessario quindi coinvolgere un’integrazione tra pubblico
e privato, definendo gli obiettivi e orientando le attività ad una crescita
globale. Ciò non è possibile finché la voglia di evadere e di inserirsi in
attività già avviate in altre regioni, caratterizza i desideri dei giovani
calabresi.
Il
discorso non vuole entrare nella secolare retorica sul contrasto Nord/Sud e
sulle false considerazioni e luoghi comuni che stereotipano una visione
della questione meridionale, ma l’analisi della situazione impone di fare
certi confronti.
Anche
Trigilia, nella terza edizione del 1992 di “Sviluppo senza autonomia”,
dimostra, dati alla mano, che il sottosviluppo meridionale e le nuove
trasformazioni della questione sono accompagnate da una diversa tipologia
di intervento pubblico e da una
diversa ricezione e interpretazione dello stesso intervento.
Trigilia
spiega come un effettivo aumento del reddito delle popolazioni meridionali
non sia accompagnato da un aumento della propensione ai consumi e agli
investimenti, proprio le variabili che ci servono per accendere il processo
moltiplicatore dello sviluppo. Viene deprecata la politica centrale, che
non può avere alcun effetto positivo se resta una mera distribuzione di
finanziamenti improduttivi. Qui Trigilia identifica le istituzioni sociali,
in particolare la Regione, come un ente che opera dal basso, equiparato ai
privati e sottomesso alle politiche statali centralizzate. Per cui
l’autonomia che si propugna non è solo un buon senso comune di impegnarsi
attivamente, ma deve essere anche una presa di posizione degli enti locali,
che devono creare una propria identità orientata ad obiettivi concreti di
sviluppo. Senza la creazione di un’identità che ripudia l’assistenzialismo
e rinnova il desiderio di confrontarsi apertamente, l’intervento pubblico non può creare effetti né in termini di
reddito complessivo, né in termini di benessere sociale.
L’identità
locale è una caratteristica che ho riscontrato peraltro nelle campagne
toscane ed in altre realtà durante miei studi precedenti.
Ad
esempio, entrando nella città di Siena, sembra di entrare in una cittadella
del Cinquecento ancora intatta,ed è tutta l’atmosfera a creare una visione
di popolazioni continuamente alla riscoperta delle loro origini: prodotti
creati come alcuni secoli or sono, strade pavimentate e restaurate nello stile
originario, ma anche le stesse tipicità dei casolari, ricreati secondo
antiche particolarità edilizie caratteristiche del Rinascimento.
Sicuramente la cultura del bello, della riscoperta delle proprie origini,
dell’estetica e della fierezza di essere calabresi, sono caratteri sui
quali bisogna insistere molto. La storia della Calabria e degli eventi
trascorsi nei secoli deve essere di dominio pubblico,
per superare l’ignoranza delle proprie origini. Naturalmente ci sono dei
dibattiti in corso in merito agli effetti perversi che potrebbe comportare un’eccessiva identità locale, ma
ancora perché questa sia eccessiva ce ne vuole.
Ricapitolando,
abbiamo analizzato l’importante
ruolo dei fattori culturali e della formazione sociale locale affinché si
crei o si incrementi il senso di responsabilità, il desiderio di
indipendenza, una cultura imprenditoriale e soprattutto, da
parte delle risorse umane regionali, la voglia di rimanere a creare uno
sviluppo concreto ripudiando le allettanti offerte di realtà già avviate.
Questa
lunga analisi sull’importanza dei fattori culturali nello sviluppo è stata
volutamente descritta perché sarebbe
facile dire che i presupposti per l’attivazione dei Sistemi Turistici
Locali sono la presenza di risorse, la presenza di una minima offerta, la
presenza o l’obiettivo di migliorare la dotazione infrastrutturale, ecc.
Tutto ciò viene dato per scontato e verrà comunque affrontato nell’ultimo
capitolo, dove sarà predisposto un Project Cycle Management relativo alla
costituzione di un STL nella Locride. È necessario, per riprendere i timori
di Becheri, e quindi per non trasformare questi strumenti in ennesimi
tentativi fallimentari di sviluppo, considerare le tre caratteristiche che
una comunità e quindi gli attori chiave devono avere:
-
Senso di
responsabilità;
-
Desiderio di
indipendenza;
-
Cultura
imprenditoriale.
Gli
enti pubblici devono quindi
investire in questo senso, oltre che nelle opere materiali, comunque
necessarie. Se l’abitante di Portigliola non sa che sotto i suoi piedi c’è
la sua storia, quindi se non la conosce, non potrà mai amarla e, se
non la ama, non potrà mai avere interesse a valorizzarla e a considerarla
una fonte di reddito.
Il
nove giugno 2003, durante un incontro con i sindaci della provincia di
Reggio nella sala consiliare della Provincia, il Presidente Fuda dava il
via all’attivazione di un processo che dovrebbe
portare alla creazione di Sistemi Turistici Locali in tutto il territorio.
Erano presenti numerosi sindaci di tutte le aree, che hanno dato il loro
contributo all’avvio dei tavoli di concertazione.
Il
nostro stage presso la Provincia di Reggio, infatti, non era rivolto alla
valutazione o alla gestione di un programma già in atto, ma proprio alla
creazione di un programma.
La
passione ci ha spinto fin dall’inizio del Master a svolgere indagini sul
territorio, a conoscere gli interlocutori, a verificare tutti quei dati
economici e sociali che nessun istituto di statistica avrebbe mai potuto fornirci.
Il
progetto presentato è ambizioso, e non a caso è preceduto da due lunghi
capitoli di teoria. Abbiamo
voluto giustificare ogni passo, motivare ogni decisione, consapevoli che
tutto il lavoro è solo una
proposta dell’equipe tecnica che lo
ha elaborato.
Adesso
spetta alle istituzioni fare delle scelte. La programmazione dal basso
implica necessariamente una predisposizione sociale. Non è stato neanche un
caso, infatti, avere scelto la Locride (che preferiamo già chiamare Riviera
dei Gelsomini), o meglio una zona strategica della Riviera. Lì vi sono
molte forze sociali, imprenditoriali, politiche e della Chiesa che stanno lavorando allo sviluppo locale. Il compito della
Provincia è quello di coordinare, promuovere e rispettare gli impegni
nell’ambito delle sue competenze. Per creare un STL, infatti, non sono
necessarie molte risorse finanziarie (quelle servono perlopiù agli
investimenti di riqualificazione), il nocciolo duro invece è costituito da
un regolamento, interno al sistema, dove ogni attore ha dei compiti da
rispettare, perché è considerato un elemento di una grande catena di
montaggio, che potrebbe fermarsi
se solo uno non assolvesse agli impegni assunti. Nel STL di Verona, abbiamo visto, chi non rispetta gli impegni viene
escluso.
La
Camera di Commercio di Reggio Calabria, più che di sviluppo endogeno, parla
di sviluppo endosogeno, perché è naturale che vi debba essere una forte predisposizione dal basso,
ma senza infrastrutture, senza servizi, gli sforzi degli attori sociali e
imprenditoriali è completamente inutile. Mentre la Regione Calabria
ha una legge sull’offerta turistica nei centri storici posata nel cassetto
dal 1988, nella Riviera vi sono diverse associazioni che stanno facendo i
salti mortali per contattare i grossi proprietari e avere in gestione
edifici dell’entroterra da offrire come ricettività. Questo e tanti altri
esempi (si invita a leggere particolarmente le interviste a Mario Diano ed
al Mons. Bregantini) ci hanno dato la conferma che la mentalità sta
cambiando.
Il
popolo calabrese non deve più rassegnarsi e scegliere vigliaccamente (si perdoni
il termine forte) l’emigrazione come via d’uscita ad un ritardo di sviluppo da sempre
auspicato e mai arrivato. Non vogliamo rimanere nell’Obiettivo 1, vogliamo
un reddito pari almeno alla media europea, non vogliamo più soldi, vogliamo
investire bene quelli che ci sono dai vari fondi e poi cominciare a
produrne da soli, per uscire da quell’economia dipendente che ci
caratterizza. Questo lavoro non
vuole essere il solito libro di favole. Abbiamo
pensato di mettere un mattoncino del castello che vogliamo costruire, ma
l’integrazione e la cooperazione, la solidarietà e la ricerca di obiettivi
comuni devono stare alla base. Tu solo puoi farcela – ha detto Mons.
Bregantini – ma non puoi farcela
da solo.
info@longonet.com
|